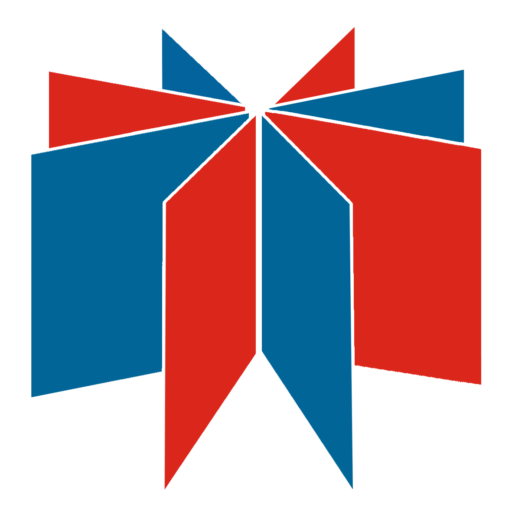di Valeria Bove / Ormai lo sappiamo tutti: a vincere la 75° edizione del Premio Strega è stato Emanuele Trevi con il suo Due Vite, edito da Neri Pozza.

A presentare l’evento c’era Geppi Cucciari, che ha bonariamente spolverato le giacche infeltrite degli epigoni dell’editoria nostrana presenti al Ninfeo di Villa Giulia a Roma, senza riuscirci fino in fondo.
Il gap generazionale e la boriosa prosopopea elitistica non sono state scalfite dai suoi commenti ironici. Noi di Librincircolo, però, vogliamo riportarvi quello che i cinque autori finalisti hanno detto sui loro libri, sul mestiere di scrivere e sulle difficoltà incontrate.
La prima a prendere la parola è Giulia Caminito, vincitrice del Premio Strega Off.
Caminito definisce il suo libro L’acqua del lago non è mai dolce (Bompiani, 2021), un romanzo di malaformazione.
Ambientato sul lago di Bracciano, nel romanzo l’acqua assurge a simbolo capace di influenzarne l’intera struttura: “la scrittura di fiume è quella che racconta le esondazioni, chi vive il mare è il viaggio, la tempesta, l’infinito, il lago è uno spazio chiuso e quindi uno spazio anche che riflette, uno spazio che può essere più malinconico”.
E ancora, il lago diventa “simbolo del sommerso […] E c’è qualcosa di sommerso anche nella pancia di Gaia [la protagonista, ndr], nel modo in cui lei costruisce e decostruisce la propria identità”. Il libro ha un’organizzazione circolare, per cui “seguiamo questa ragazzina da piccola nelle sue difficoltà, nella famiglia e ci sono le varie tappe in cui lei potrebbe evolversi, crescere, formarsi, ma in realtà non fa altro che scalciare, aggredire, cadere. […] quindi è come un gioco dell’oca: lei sbaglia la casella e viene rimandata al via”.
È questa sensazione di fangosa impotenza che Caminito collega alla propria generazione impantanata: “quella difficoltà di accedere a qualcosa, quei tentativi di rivoluzioni che poi non arrivano, quella voglia di cambiare completamente gli aspetti della propria vita”.
Ma il ritorno al via è anche il momento in cui Gaia impara di “saper prendere la mira e sparare”.
È poi il turno di Andrea Bajani con il suo Il libro delle case (Feltrinelli Editore, 2021).
Bajani parla della filosofia dietro al suo romanzo e crede che per raccontare una vita “l’unica possibilità è setacciare le sue case, cercare gli indizi di quel piccolo inevitabile crimine che è dire “io”, sapendo però che dietro c’è sempre una menzogna”.
Bajani è poeta, oltre che scrittore, e dice di essersi affidato alla musica per Il libro delle case, ma anche ad altro: “questo libro, costruito per istantanee che vanno su e giù nello spazio e per il tempo, è come se fosse per me un poliziesco, il poliziesco dell’identità, cioè noi siamo stati qualcosa e quindi, in qualche modo, l’unica possibilità di rincontrare quello che tu sei stato è fare questa operazione impossibile che è andare nella casa in cui avevi 16 anni e tentare di incontrarti, costruendo una architettura di indizi sulla base della quale il lettore è chiamato a intervenire.
Ecco, scrivere Il libro delle case, per me voleva dire accetto e mi prendo cura di tutti gli io che sono stato e se non sono stato un buon io, pazienza, ha comunque diritto di cittadinanza in questo libro”.
È poi la volta di Emanuele Trevi con Due Vite, in cui racconta le storie dello scrittore Rocco Carbone e della scrittrice e traduttrice Pia Pera.
“Mi interessava vedere queste due persone dentro un aspetto di realizzazione artistica e dentro un aspetto precedente di completa incertezza del futuro”. Trevi ammette di “aver avuto maggiore facilità di trattamento del maschile”.
Per l’autore, il libro diventa una pratica per redimere gli sbagli della giovinezza e per “allungare la memoria” di amici che non ci sono più, all’insegna di un carpe diem esistenziale.
Sullo scrivere di persone realmente esistite, Trevi ci dice “se io penso a una persona o se la sogno, è un po’ una proiezione. Se ne scrivi […], mortifichi il tuo ego, la tua volontà e quindi appare con una specie di sua propria volontà la persona assente che ti manca, il motore della scrittura è proprio la mancanza”.
A seguire Donatella Di Pietrantonio con il suo Borgo Sud (Einaudi, 2020), “un romanzo sulle conseguenze del disamore”.
L’autrice riprende la storia delle due sorelle già protagoniste de L’Arminuta (Einaudi, 2017) e le segue nel loro viaggio nella vita adulta, con tutte le conseguenze dell’essere cresciute in una famiglia anaffettiva.
A Borgo Sud, però, si palesa loro un ritrovato senso di comunità, “qui tutto è più lento e forse più umano”. Di Pietrantonio sente i suoi personaggi, ma “le loro voci si sono placate” e si dice pronta per una nuova storia, per nuove vite. Lo stile asciutto dell’autrice rivela poi qualcosa sul suo essere anche lettrice: “è molto importante lasciare uno spazio in cui il lettore possa mettere del suo, perché per me, da lettrice, è molto fastidioso quando un libro mi consegna tutto, […] quindi io ho bisogno, prima di tutto da lettrice, che mi si lasci uno spazio di libertà e di immaginazione e cerco di farlo anche nella scrittura”.
Sui problemi nella stesura del suo libro, Di Pietrantonio dà una testimonianza importante: “la svolta c’è stata quando mi sono spostata in avanti con il punto di vista, quindi quando ho cominciato a raccontare con una voce più matura, più vicina all’età di mezzo che io stavo e sto vivendo”.
Alla fine della sua intervista, Donatella mostra alle telecamere una scritta sul palmo della mano: “ddl Zan”, a supporto della comunità LGBTQ+ e che ci sentiamo di condividere.
A chiudere il cerchio è Edith Bruck con Il pane perduto (La Nave di Teseo, 2021), vincitrice del Premio Strega Giovani.
Bruck descrive il suo romanzo come “una favola in bianco e nero […] Comincia in Ungheria, nel mio piccolo villaggio di infanzia nel ‘44, arrivano i fascisti, i gendarmi ungheresi deportano la mia famiglia, arriviamo in Auschwitz, poi altri 6 campi diversi di lavoro e annientamento e questa ragazzina, che correva felice nell’infanzia […] lotta per la propria vita con la sorella maggiore che l’aiuta e riescono miracolosamente a sopravvivere”. Bruck racconta di essere sbarcata a Napoli nel ‘54 e di essersi detta “qui posso vivere”. A Roma ha poi incontrato anche l’amore della sua vita e con Il pane perduto ha voluto dedicargli una lettera d’addio.
Nel suo libro, Bruck fa un viaggio a ritroso nel suo doloroso passato che, insieme a Liliana Segre, ha raccontato a tantissimi giovani studenti, affinché non dimentichino. Il racconto diventa quindi la sede attiva della memoria: “importante è raccontare, importante testimoniare ai ragazzi quello che è stato perché si insegna poco e male nelle scuole”.
Si lascia poi andare a un commovente ricordo del marito, ammalatosi di Alzheimer: “Non ho mai avuto genitori vecchi, nonni vecchi, e mi pareva che attraverso la cura che ho dedicato a mio marito, tenevo in vita anche loro”.
Anche Bruck ammette di aver avuto un “attimo di amnesia”, ha iniziato a scrivere subito, tornando indietro con la memoria e ritrovando quella bambina di 13 anni che ancora vive in lei.
L’autrice rivela anche di scrivere tutto a mano, trascrivendo successivamente a macchina o a computer: “è un rapporto corporale tra me e la penna”. La scrittura si riconferma, così, indispensabile sede della memoria, modalità di creazione di uno limbo intermedio in cui nessuno muore, in cui è possibile mentire, ma anche raccontare eventi dolorosi o dissidi generazionali.
La vittoria di Trevi sembra riassumere tutte e cinque le personalità dei finalisti.

E allora suonano profetiche le parole di Giovanni Solimine, presidente della Fondazione Bellonci, all’inizio della serata: “è importante il risultato di vendite, ma è importante offrire spunti, offrire occasioni alle persone per ritrovare dentro i libri la propria vita, le proprie storie e scoprire le storie e le vite degli altri”.